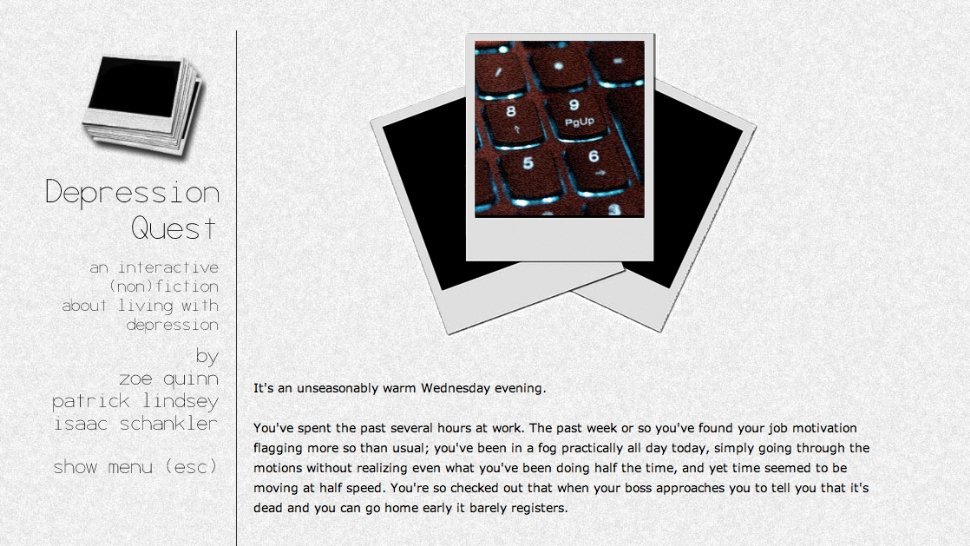I videogiochi hanno innanzitutto il compito di intrattenere e divertire migliaia e migliaia di appassionati di ogni genere che, pad alla mano, staccano per qualche ora la spina da tutto ciò li circonda, dimenticando la loro routine quotidiana e rifugiandosi in mondi inesplorati. Il videogioco è innanzitutto un mezzo di svago, nato senza troppe pretese di insegnamento o risvolti morali che, con qualche semplice pixel, linea e animazione, era in grado di catturare per ore e ore la fantasia di tutti gli appassionati e frequentatori di fumose e grigie sale giochi perché, non negatelo, anche voi vi sarete con ogni probabilità avvicinati a questo mondo spendendo gettoni o cinquecento lire in questi luoghi di ritrovo. L’evoluzione del media ha però tracciato nuove strade, le contaminazioni sono sotto gli occhi di tutti e ora, tracciare una linea netta di separazione tra videogiochi, libri e cinema – almeno per certi aspetti – è molto più complicato, tant’è che sempre più spesso si avvicinano i termini “videogiochi” e “arte”. Slegati da vincoli di bilancio e da margini di profitto da far maturare, piccoli team indipendenti danno luogo a vere e proprie piccole perle che, come i recenti Inside o Abzu, sono in grado di fare emozionare chiunque gli si avvicini, grazie ad una direzione artistica magistrale.

Un male incurabile
Definire un videogioco come una semplice forma di intrattenimento è oramai limitante, esclude le sperimentazioni in corso, non tiene conto dei valori che essi cercano di trasmettere ma, nonostante tutto, il loro ruolo di forma di svago rimane ancora ben presente. Questo è vero nella maggior parte dei casi, ma non sempre. Nel caso vi siano sfuggiti, nel recente passato e nel prossimo futuro, si stanno facendo largo produzioni che cercano di toccare temi scottanti, e non stiamo parlando di banalizzazioni come l’odio, l’amore o la pace, né tantomeno di viaggi pindarici pseudo-filosofici come quelli proposti da un The Talos Principle (che rimane un capolavoro, sia chiaro), ma di fatti concreti e reali che, da vicino o da più lontano, toccano tutti noi. Stiamo parlando di titoli come That Dragon, Cancer, No Pineapple Left Behind o il prossimo The Day We Left, giochi che ti colpiscono come un pugno allo stomaco, che non vogliono far divertire il giocatore, che hanno meccaniche semplici e lineari, il cui unico scopo è quello di costringere l’utente a fermarsi per un attimo e rendersi conto che i problemi esistono, non vanno banalizzati e caratterizzano il corso della vita di tutti noi.
La storia di That Dragon, Cancer è forse una fra le più note e il titolo non avrebbe bisogno di molte presentazioni, trattandosi di una delle produzioni più crude e difficili da digerire, che, come dice il nome stesso, prende in considerazione forse una delle malattie più dure da affrontare, sia per chi ne è colpito, sia per chi fa parte della cerchia di affetti del malato. La storia e l’intreccio coinvolgono, legano, allontanano e alla fine strappano Joel, un bambino di soli quattro anni, dalla coppia di genitori – Ryan ed Amy. È straziante ed emotivamente stordente, non fa nulla per alleviare il dolore di una malattia nello stadio terminale e viene raccontata sia tramite scene oniriche, alle volte quasi divertenti, come la finta gara di go-kart fra le corsie dell’ospedale, sia con dialoghi all’estremo della sopportabilità per le parole profuse dal dottore che spiega al padre e alla madre come Joel sia oramai condannato ad una morte prematura. That Dragon, Cancer è un videogioco che si confonde con la realtà, la realtà stessa del piccolo team di sviluppo Numinous Games, guidato proprio da Ryan e Amy Green, i protagonisti dello stesso videogioco.
Essi hanno voluto condividere e far conoscere al mondo la propria drammatica storia, raccontando in un semplice videogioco il tragico destino di Joel. Non ci sono buonismi né tentativi di commuovere con frasi fatte o situazioni volutamente esasperate in That Dragon, Cancer, ma c’è solo il tentativo umano di una coppia di sperare fino alla fine nella salvezza del proprio figlio, standogli vicino e facendo inoltre capire la situazione ai suoi altri fratelli, colpiti anche loro dal dramma. That Dragon, Cancer non è un gioco per tutti e non vuole esserlo, ma di certo è un passo avanti, forse nel vuoto, per un’industria videoludica che sta cercando di distaccarsi dai suoi canoni usuali, e tratta il tema di una malattia mortale, uno dei tabù della nostra società, in un modo del tutto impensabile fino a pochi anni fa.
Testa di pigna
La storia di No Pineapple Left Behind è sicuramente meno nota e, almeno per il modo con il quale vengono trattate certe tematiche e per il suo gameplay, non si rivela essere una esperienza così d’impatto come il gioco precedente. Ma esattamente, cosa è No Pineapple Left Behind? Il titolo sviluppato da Subaltern Games si presenta come un assurdo gestionale dove, vestendo i panni di un direttore di una scuola americana, si cerca di far tirare avanti il proprio istituto accaparrandosi i fondi statali. Fermandosi all’apparenza, si potrebbe prendere No Pineapple Left per uno dei tanti giochi indipendenti tranquillamente dimenticabili sullo store digitale di Valve ma, indagando più in profondità, viene a galla una questione molto più seria e spinosa che parte da Seth Alter, fondatore della stessa Subaltern Games.
Alter, prima di dedicarsi ai videogiochi, era infatti lui stesso un insegnante di una scuola americana ed il nome del suo gioco deriva direttamente da una legge americana entrata in vigore nel 2001 e chiamata No Children Left Behind che, senza scendere troppo nei dettagli, lega i sussidi statali diretti ai singoli istituti alle prestazioni degli alunni, creando così una evidente stortura, una situazione in cui i docenti erano costretti a impartire lezioni sempre identiche, uniformi e volte solo ad ottenere una nozione mnemonica e non critica dei concetti, per ottenere voti alti e quindi fondi per non far fallire la propria scuola.
Questa procedura di standardizzazione, che non tiene conto delle peculiarità dei singoli ragazzi, è stata ricreata tramite un’allegoria in
No Pineapple Left, dove gli alunni migliori che non hanno alcuna distrazione sono senza un nome, non provano alcun sentimento e non hanno interazioni con gli altri compagni sono trasformati letteralmente in ananas tutti uguali. La critica aspra verso il sistema scolastico americano si fa ancora più evidente e spinosa quando ci si accorge che, livello dopo livello, l’unico modo per vincere la sfida e non far fallire l’istituto è quello di assumere e licenziare di continuo gli insegnanti, di placare i loro mal di pancia e i loro scioperi con l’ausilio della polizia e di utilizzare incantesimi per azzerare l’emozioni e le distrazioni degli studenti. Cosa rappresentano le assurde magie? Molto semplice: il fitto sottobosco di farmaci semi-illegali che pullulano nelle scuole americane e che hanno il compito di alzare la soglia di concentrazione degli alunni. Quello che Alter vuole farci capire è che la “managerializzazione” deve rimanere fuori da certi ambienti e, nonostante sia un tema principalmente americano, questo fenomeno è sempre più in atto anche nel Vecchio Continente, dove l’adozione dei cosiddetti test OCSE-PISA sta distorcendo l’apprendimento delle discipline logico-matematiche, come evidenzia l’accusa lanciata da Giorgio Israel e riassunta nel suo breve testo chiamato “
Il bluf della matematica in Finlandia“.

Senza sapere dove andare
Dalle vicende personali ma comuni a tutti di That Dragon, Cancer, passando per gli argomenti magari meno drammatici ma più complessi di No Pineapple Left Behind, arriviamo infine al tema più di attualità, prodotto di anni e anni di incessante guerra, a volte dichiarata e alle volte più nascosta, che prende il nome di dramma dei rifugiati. Non passa infatti un giorno senza che qualche telegiornale ne parli, che qualche opinionista si arroghi il diritto di dire la sua senza reale cognizione di causa, infarcendo la testa del suo pubblico di idee magari lontane dalla verità e nascoste dietro un velo di ipocrisia, volto solo a spostare qualche voto in nome della paura. The Day We Left, la cui data di uscita è fissata per la metà del 2017, cerca di distaccarsi da queste chiacchiere da salotto e, tramite un videogioco a metà strada tra un’avventura grafica e il survival, mette in scena il dramma di una famiglia costretta a scappare dalla propria città a causa della guerra e che, segnata da lutti famigliari, decide di intraprendere un viaggio della speranza attraverso il deserto in cerca di fortune, lasciandosi alle spalle un paese ridotto oramai in macerie.
Inner Void, team di sviluppo italiano, avvalendosi di storie vere raccontate da rifugiati, ha cercato di ricostruire il punto di vista umano di chi scappa dalla guerra, staccandosi dalla nostra dicotomia che dipinge questi uomini e donne come buoni o cattivi, dando una prospettiva molto più incentrata sulle relazioni che intercorrono tra i componenti dei gruppi di fuggitivi. Rashid, questo il nome del protagonista, è innanzitutto un padre di famiglia costretto a strappare dalla quotidianità i suoi figli cresciuti troppo in fretta fra bombe e lutti, che ha intrapreso un viaggio tra check-point di soldati ribelli e dell’esercito e che corre quotidianamente dei rischi mortali solo per raggiungere la normalità. Il progetto di Inner Void è quanto mai ambizioso e per nulla lineare, dato che nel corso dell’avventura i compagni di viaggio e famigliari di Rashid possono ammalarsi e morire. Il viaggio che intraprenderanno caratterizzerà i loro comportamenti in maniera definitiva.
Forse, il migliore manifesto di cosa vuole essere e di come deve essere preso
The Day We Left lo hanno scritto gli stessi sviluppatori: “
Non rappresenteremo i rifugiati come invasori né come eroi, ma solo come gente disperata che scappa dalla propria patria, lasciando che sia il giocatore a trarre le sue conclusioni sull’argomento. Come sappiamo tutti, un approccio etico dualistico non è sufficiente per descrivere una persona che non può essere giudicata soltanto ‘buona’ o ‘cattiva’. Una persona è un complesso di emozioni, obiettivi, ricordi e qualità, e il giocatore incontrerà pertanto personaggi con cui si troverà d’accordo e individui che disprezzerà, anche se dipenderà per buona parte dall’opinione politica e dalla visione del giocatore stesso“. Attualmente,
The Day We Left sta crescendo tramite una raccolta fondi su Kickstarter e, nel caso in cui vogliate sostenere il progetto – una parte del cui ricavato andrà ad associazioni di beneficenza – eccovi il
link della campagna, dove potete anche scaricare la demo gratuita.
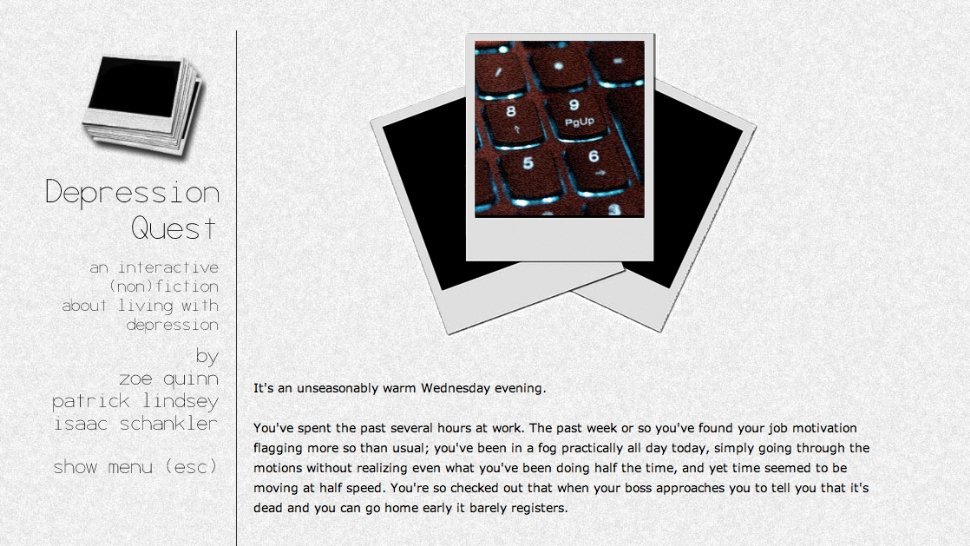
È questo il futuro dei videogiochi? No.
That Dragon, Cancer, The Day We Left, No Pineapple Left Behind, ma anche altre produzioni come Depression Quest o Together: Amna & Saif sono tutte unite da un unico filo rosso e sono forse il manifesto di come il media videoludico non sia solo adatto a raccontare le avventure di uno Strigo, a simulare una partita di calcio virtuale o una guerra del futuro tra uomini-robot e il cattivone di turno. All’opposto è però innegabile come certe creazioni, almeno per il momento, continueranno ad essere appannaggio di piccoli team di sviluppo indipendenti, coraggiosi nel proporre titoli che ben si distaccano da quello che passa nei canali mainstream, ma che difficilmente passeranno per le mani di chi consuma il media solo per cercare qualche ora di svago.
In fin dei conti è però anche giusto e normale che sia così, la natura di un videogame deve comunque rimanere principalmente quella di mezzo di intrattenimento e biasimare chi sfrutta le console o il pc solo per staccare dal caos che lo circonda sarebbe di una ipocrisia senza confini, ed è comprensibile capire come certi aspetti drammatici e difficili della vita non possano andare giù a tutti, soprattutto quando si è seduti davanti a uno schermo per giocare. Quello che va però riconosciuto e per il quale certe software house devono essere ringraziate, oltre per l’importanza data a certi temi, è lo sbattere in faccia al mondo come il videogioco, proprio come quasi ogni mezzo, non sia né buono né cattivo. Un gioco non è un prodotto solo per ragazzini o adulti poco cresciuti, ma anzi può essere lo strumento più adatto per far conoscere a certe generazioni argomenti e tematiche che spesso la televisione o gli altri mezzi di comunicazione classici tralasciano volutamente o trasmettono in modo inappropriato.
I videogiochi sono arte? Questa domanda viene sempre più spesso ripetuta in modo vuoto e, almeno personalmente, ha abbastanza stufato e nella maggior parte dei casi sfocia in discussioni sterili. Quello che realmente sta accadendo – almeno sotto la superficie più commerciale – e su cui forse varrebbe più la pena concentrarsi, non è tanto la commistione tra i videogiochi e le altre forme di intrattenimento, quanto la creazione di titoli fuori da ogni canone, il cui scopo è innanzitutto quello di trattare argomenti difficili, alle volte pesanti come un macigno – come la malattia o la guerra – ma che innalzano il media verso nuovi orizzonti, meno vicini all’intrattenimento e più simili all’informazione. Prospettare che il futuro dei videogiochi sia questo è improbabile, forse fortunatamente, perché in fin dei conti essi devono innanzitutto divertire e creare svago, ma queste produzioni stanno certamente dando una mano fondamentale al media, il quale vuole affrancarsi da schemi stringenti – spesso sbagliati e figli di preconcetti – nel quale è sempre stato rinchiuso.